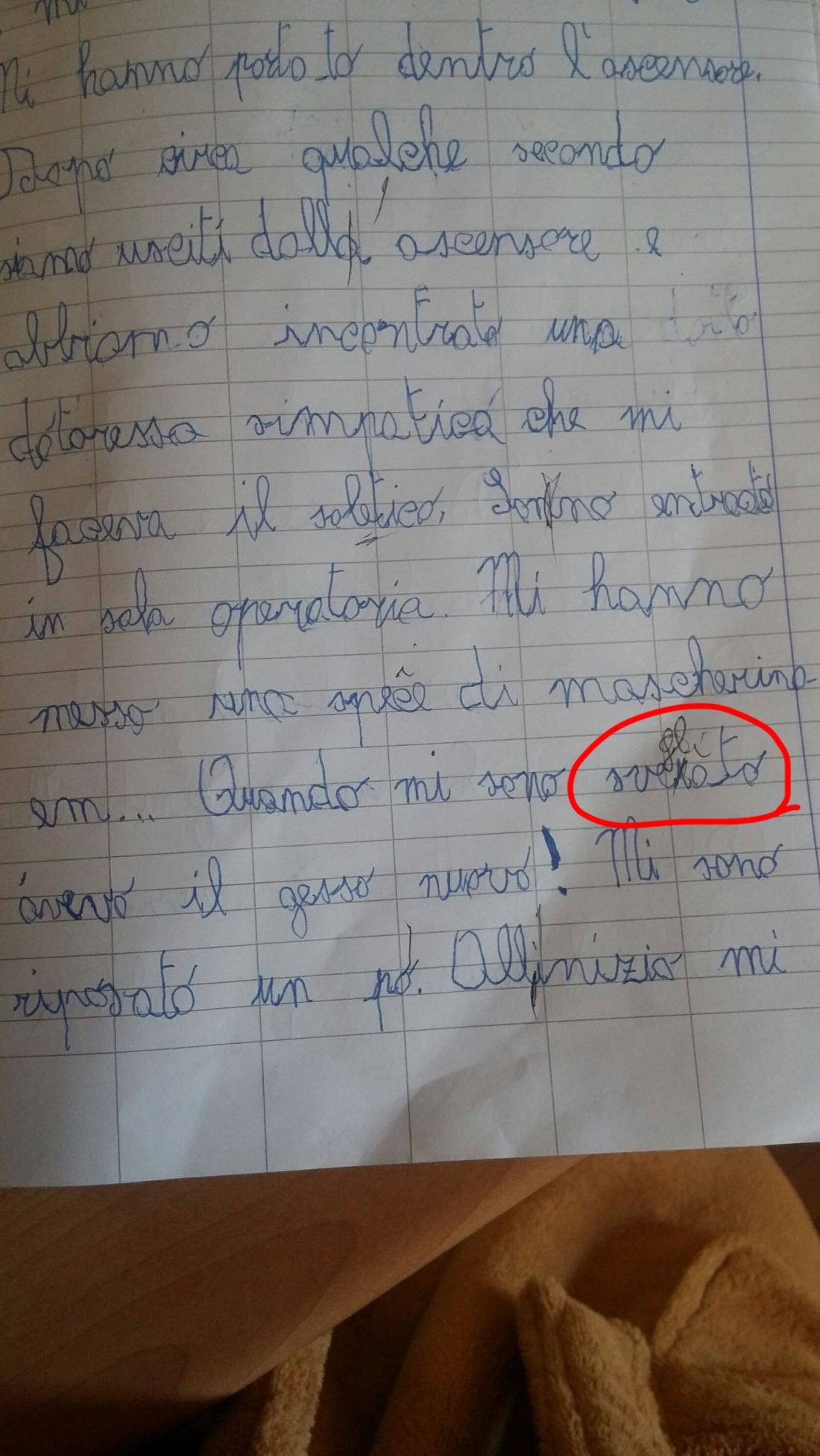premessa: questo post vuole rappresentare anche il trait d’union fra questo e il nuovo blog su gioie e dolori della maternità. Ho forti dubbi sulle mie capacità di scrivere addirittura su due blog quando per scrivere questo post ci ho mess ben due settimane di scampoli di tempo, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.
_____________________________________
Io e mio (come definirlo? Ragazzo? Con un figlio sembra ridicolo! Compagno? Affettato!) marito non siamo mai stati quel tipo di genitori che “mio figlio a 7 mesi risolveva gli integrali impropri”.
Un po’ perché siamo dei tipini modesti, ma più che altro perché non ce lo possiamo permettere. Il nostro piccolo toporagno non si è mai prodotto in nessuna performance che a noi sembrasse particolarmente precoce perché potessimo vantarcene in giro, anche a rischio di ricevere uno di quei soliti sorrisi di circostanza dei tipi a) “ecco un altro genitore convinto di allevare la nuova Montalcini”; b) “il mio lo faceva a metà della sua età”; c) “che cosa preparo stasera per cena?.
Mettiamo subito in chiaro che mio figlio non è che sia tardo, rimbambito o faccia tappezzeria…. ANZI!!! Diciamo che mi dà del filo da torcere è che è in moto perpetuo. E’ solo che per quanto riguarda quei traguardi che vengono considerati tappe nello sviluppo infantile e la cui tempistica è orgoglioso tema di discussione e confronto tra le mamme alle altalene, semplicemente non ha stabilito alcun record da guinness: ha gattonato a 9 mesi, camminato a 13, si è tirato su con un sostegno a 8. Certo, suscitava un po’ di stupore misto ora ad ammirazione ora a biasimo (verso di me) il fatto che abbia usato il vasino la prima volta a 5 mesi e mezzo, ma in effetti ero io a metterlo sul vasino quando vedevo che era il momento (per approfondire vedi EC): è andata avanti così fino ai 10 mesi, a volte senza nemmeno un pannolino sporco in una giornata, poi però non è più riuscito a stare fermo quei 2 minuti necessari all’espletamento. Ci sono poi campi in cui è decisamente come un neonato, quali quello dell’alimentazione: quando ero incinta mi ricordo che leggendo lo sviluppo del feto settimana per settimana mi fece una certa impressione pensare che in quel determinato periodo si stavano formando le unghie, e siccome ero molto stanca scherzando dicevo a mio marito che fare le unghie a un bambino, ben 20, non era mica cosa da nulla! Ecco, ora lui mi rimprovera dicendo che mi sono concentrata troppo sulle unghie e mi sono dimenticata qualcosa nel primo tratto dell’apparato digerente. In pratica Flavio non è molto abile nelle deglutizione/masticazione, e fino a più di un anno non era nemmeno in grado di sbocconcellare un biscotto senza vomitare. Sono stata costretta per molto tempo a frullargli anche la minestrina, e ancora adesso non andiamo molto più in là della dimensione dei grattini.
Ma insomma, qui volevo parlare di una conquista affascinante, misteriosa e… travagliata: quella del linguaggio.
Allora: la prima parola di mio figlio è stata BITTO. Aveva 4 mesi, poppava serenamente, quando ad un tratto si è interrotto, mi ha guardata seriamente e con molta convinzione ha detto: BITTO. Non abbiamo mai capito cosa volesse dire, e non si è ripetuto presto, ma la cosa strana è che ora questa parola è risaltata fuori dal nulla e tutt’ora non riesco a trovargli uan collocazione semantica: mi indica il muso di alcune mucche su un libro ( e solo su quello) e mi dice BITTO, BITTO, BITTO!!!! Scandendolo ogni volta come a dire “ma che sei de coccio?”.
La prima parola con un senso ben percepito ovviamente è stata MAMMA (e lo avevo minacciato di morte se avesse detto prima “papà”), però non è stato emozionante come me l’ero immaginato perché non è che di punto in bianco mi ha guardato negli occhi con amore scandendo “mamma”: è stato più un mammammammamma che si è evoluto pian piano. Non saprei dire quando ho avuto la consapevolezza che si rivolgesse proprio a me, anche perché per un sacco di tempo l’ha detto solo quando era proprio disperato, tipo urlo di dolore.
Chiaramente in seguito, parecchio dopo, è venuto PAPA’. E’ interessante che le parole per “mamma” e “papà” siano pressoché foneticamente universali perché interessano il luogo di articolazione labiale, il primo che, per ovvie ragioni di sopravvivenza, il bambino impara ad esercitare da subito.
A parte queste due parole, il periodo del silenzio è stato molto, molto lungo. A dire il vero non si trattava di vero e proprio silenzio, anzi era un chiacchiericcio continuo, ma che alle nostre orecchie aveva poco o nessun senso. Verso i 18 mesi si sono aggiunti dei monosillabi a cui abbiamo potuto attribuire un significato preciso: STA significava “stella”, e la presenza del concomitante LA per “luna” purtroppo mi impediva di vantarmi del fatto che mio figlio in realtà parlasse inglese. Anche se non amo i confronti, e sono convinta che la tempistica di queste tappe non abbia nulla a che vedere con l’intelligenza o il futuro successo del pargolo, voglio qui ricordare l’incontro di Flavio con una sua coetanea con delle doti linguistiche veramente sviluppate, che a 18 mesi parlava meglio di tanta gente adulta che conosco. Stavano seduti vicini sul divano e mentre lei gli mostrava il suo libro presentandogli tutti i componenti della famiglia Barbapapà per nome e lui ascoltava compito, finché alla vista del disegno di una stellina si è animato tutto ed ha cominciato a puntare il dito sulla pagina e a ripetere ad alta voce “STA, STA, STAAA!!!”, impedendo all’amichetta di girare pagina. Della serie “questa la so e la devo dire!”.
Per amore di completezza devo specificare che da ieri LA è diventato finalmente LUNA, ma questo tipo di contrazioni è ancora molto in uso nel flaviesco. Ad esempio “comignolo” è CHIGNOLO, ma molto più interessante è CANNO, che vale tanto per “cavallo” che per “cappello”: con l’omissione della sillaba centrale e la doppia L realizzata come NN le due parole diventano identiche. La laterale intensa (la doppia L) subisce modifiche anche in “palla” e “farfalla”, diventando ancora una volta una nasale, la M: PAMMA, FAFFAMMA. C’è perfino un caso di anagramma; “luce” è CIUE o più spesso CIU.
La fonetica del flaviesco è proprio articolata e interessante come quella di una qualsiasi lingua o dialetto naturale: evidentemente c’è la percezione della differenza fra le fonemi consonantici normali o intensi, che però vengono trattati in modo diverso. Abbiamo visto che la doppia L diventa una nasale, mentre la L singola per lo più non viene pronunciata (CAE “cane” o PAE “pane”). Sulla rotante (R) (FEO TTIO “ferro da stiro”) non mi soffermo nemmeno: posso dire tranquillamente che è uno dei fonemi che si imparano a pronunciare più tardi.
Concludo questa sezione fonetica con una serie di affricate palatali (cioè il suono C di “cena”) che sono l’esito di gruppi consonantici “complessi” come “S + consonante” o l’altra affricata dentale Z (che poi si può considerare come un gruppo consonantico complesso TS): CIOCCO (“biscotto”), BOCCIO (“mostro”),A COCCIO (“a posto”), CIOCCIO (“zozzo”, “sporco”) BUCCIA (“mosca”), BUCCIOLA (“puzzola”), e… CIACCHI (“scarpe”). Da notare come tanto M quanto P diventano semplicemente B: viene “azzeccato” il luogo di articolazione labiale e per semplificarsi la vita viene scelta la B come realizzazione di tutte le altre labiali (la P pure occlusiva ma sorda, e la M bilabiale nasale).
La morfologia nominale è ancora molto in via di sviluppo: ogni parola viene pronunciata sempre al singolare o al plurale a seconda di come è stata percepita quando l’ha imparata la prima volta: CIACCHI è sempre plurale, anche se viene indicata una sola scarpa. Anche BIBBI “bimbi”, nato da frasi come “andiamo al parco dai bimbi”, all’inizio valeva anche per un solo bambino, poi pian piano si è aggiunto un plurale maschile, BOBBO, con un’assimilazione vocalica regressiva dall’ultima sillaba a quella precedente (praticamente un classico della fonetica: in molti dialetti del centro-sud, così come in alcune lingue germaniche, la vocale precedente subisce una serie di “turbamenti” ad opera della vocale che segue), così come “Pippo” era POPPO. Per un bel po’ di tempo BOBBO valeva sia per maschi che per femmine, poi conseguentemente è stato coniato BABBA per le femminucce. Da qualche settimana però le assimilazioni sono sparite e vengono pronunciati correttamente BIMBI,BIMBO, BIMBA, PIPPO.
Nel flaviesco vanno per la maggiore le onomatopee: oggetti che fanno un rumore particolare non meritano altra denominazione. Tutto ciò che gira o frulla è VOOO (ventilatore, condizionatore, asciugacapelli, frullatore), tutto quello che ha ruote o viene trascinato è BRUM BRUM, tranne la macchina che è MEEE MEEEE, tutto quello che spruzza è TSCH TSCH. Ci sono anche “azioni onomatopeiche”: PUM (è caduto qualcosa), BUM (ha sbattuto una parte del corpo e si è fatto male), TUN (una porta o una finestra ha sbattuto). Il treno è CIU CIU, mentre il poppare è quasi uguale ma pronunciato tutto attaccato CIUCCIU’: entrambi da non confondere con “luce”, che è un CIU singolo. “Mamma oca” è diventato una volta “QUA QUA MAMMA”, e da allora tutte le oche, indipendentemente dalla presenza o meno di QUA QUA BIMBI, sono madri.
Rimanendo nell’ambito delle figure retoriche, troviamo una metonimia: CRANNI (“grande”) per “elefante” (oggetto designato per una sua qualità).
Ci sono poi dei nomi che abbiamo decifrato perché legati chiaramente a un oggetto che lui ci indica senza ombra di dubbio, ma la cui trafila fonetica è del tutto oscura: STA (“aspirapolvere”), CI (“parmigiano”), TI (“occhiali”). Poi c’è ACCU che è “gatto”, e di cui non mi spiego la persistente difficoltà nella doppia TT, che altrove è pronunciata correttamente.
Particolarmente notevole per una linguista è la sintassi verbale: di verbi ce ne sono ancora pochi e in principio fu solo ATTACCA, seguito immediatamente da STACCA. La coppia verbale valeva per tutta una serie di cose che fanno “clack” o per “mettere/togliere” (in generale o di abiti), “accendere/spegnere”, e tanti altri ambiti d0uso che ora non mi vengono in mente. Pian piano vi si stanno affiancando verbi più specifici ma ancora senza un contrario, come , API (“apri”), o CCENNE (“accendere”), che risulta uguale a CCENNE “scendere”, affiancato da SAI (“salire”). La cosa interessante è che tutta questa prima serie di verbi è all’imperativo singolare, che è il primo modo verbale imparato e impiegato nel primo stadio dell’interlingua, vale a dire il sistema linguistico in continua evoluzione di chi impara una lingua straniera. Molti ed accurati studi hanno dimostrato che uno straniero impiega per primo proprio l’imperativo, che è la forma che sente più spesso e dunque si imprime per prima nella memoria, e figuriamoci se ciò non è tanto più vero per un bambino, cui ahimé ci si rivolge per il 99 % proprio con l’imperativo. Altra forma del primo stadio dell’interlingua è la seconda persona singolare dell’indicativo, il che si spiega facilmente con le domande dirette che si rivolgono allo straniero: “vai via?”, risposta: “sì, io vai a casa adesso”). Da ieri Flavio per dire che voleva qualcosa si è espresso con “VOI, VOI, VOIIII!!!”: ovvio, dal momento che si sente sempre ripetere “Flavio, vuoi un biscotto, vuoi un po’ d’acqua, vuoi la pizza?”.
Ciò mi riporta alla mente il mio storico amico ed ex coinquilino tedesco, Henning, che alle prese con le prime interazioni in italiano, si esprimeva spesso alla seconda persona singolare anziché alla prima, e mentre cucinavamo una volta mi disse “hai messo il sale nell’acqua” e io “no” e lui “sì, hai messo il sale nell’acqua!” e io “no, non l’ho messo!”. Chiarito l’equivoco, lui stesso giorni dopo mi raccontò, quasi “a sua discolpa”, un aneddoto simpatico di cui era stato spettatore: un bambino piccolo diceva alla mamma “Vuoi un gelato! Vuoi un gelato!” e la mamma “VOGLIO un gelato!”, e il bambino “Anch’io! Anch’io! Anch’io VUOI un gelato!”.
Ultimamente ha fatto la sua comparsa anche il participio passato: APETTO/CUCIO (“aperto/chiuso”), ACCESO, FATTO. Manco a dirlo, gli studi sull’interlingua dimostrano come il quadro verbale si arricchisca del participio passato in un secondo momento, quando il primo stadio (la forma più frequente, quella dell’imperativo, come semplice nomenclatore di azioni) è acquisito e subentra la necessita di esprimere l’aspetto di “azione compiuta”. Più di uno studioso dell’interlingua si è spinto in un forse eccessivo e forzato parallelismo tra sequenze di apprendimento della lingua materna e della lingua seconda: è evidente che già le capacità cognitive totalmente diverse degli uni e degli altri individui interessati, la presenza o meno di una lingua altra di riferimento, e tanti altri aspetti che non è il caso di approfondire qui sconsigliano di calcare troppo la mano su questo punto, però è innegabile che alcune similitudini ci sono.
Per finire – per il momento: l’avventura della lingua è appena cominciata – è degno di menzione l’uso di ECCOLO/ECCOLA non solo per gli oggetti ma anche per azioni, per il coronamento di uno sforzo: “CCENNE, CCENNE! – mentre cerca di scendere da qualcosa – ECCOLO CCENNE!”; “API, API, API… ECCOLO API!”.
Insomma, il toporagno ha ancora una lunga strada davanti a sé, e finora la frase più complessa e completa in cui si è prodotto è “API LA POTTA!” di poco fa. Tempo fa un’amica mi disse con molta convinzione di aver letto nonché sentito confermare da un’esperta pedagoga che i bambini che imparano a parlare troppo presto e troppo correttamente mostrano un’associazione precoce e biunivoca tra oggetto e nome che è spia di una mente razionale, mentre quelli che imparano a parlare sul serio più tardi si danno alla sperimentazione linguistica in ciò mostrando una maggiore flessibilità mentale e maggiore fantasia, un temperamento più “artistico”. Non ho le basi per valutare la fondatezza di queste teorie, se rispondano a verità o se siano il classico, come si dice a Roma, “consolamose co l’ajetto” di chi magari ha avuto un figlio che ha parlato tardissimo. Posso solo dire che ovviamente nel caso di Flavio, non perché è mio figlio, ma è proprio così.